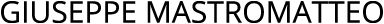Walter Guadagnini
CAMERA Director – Italian Centre for Photography, Turin
The blind jury
It is a portrait taken
by Étienne Carjat, a rare example of the face
of Arthur Rimbaud.
The poet Mastromatteo comes closest to with this work, his gaze on others embodying the perfect translation of the French genius’s “Je est un autre”. A photograph which became something more, something else, in the minds of the sick and creative people in the New York Seventies: the mask (squared) of an artist no less a dissolute rebel than the author of the Bateau ivre – David Wojnarowicz, who would roam the streets of the Big Apple wearing a mask made from Carjat’s photo. Rimbaud in New York is the didactic title of a magnificent and brilliant series by an extreme artist, who kept company with other brilliant dropouts like Peter Hujar or Nan Goldin, late-century decadents just like their predecessors, who enlivened the French capital a hundred years previously (further attesting to the shift in centrality between Europe and the United States halfway through the American Century). But we were speaking of Rimbaud, primarily, and of Carjat. That is, of the origins of photography: the means that changed our way of viewing and experiencing the world, the mechanical eye so dear to the Surrealist and Bauhaus avant-garde movements, the “safest means of poetic expression and the swiftest method to detect the delicate osmosis which develops between Surreality and reality”, in the words of Dalí prior to his transformation into Avida Dollars. The tool that sees beyond what’s real, thus coming up against the invisible, against the blindness not of the prophet (Rimbaud, again), but of the photographer who measures himself against the world through paradoxes – such as Strand’s picture the blind beggar woman (in New York, again) with the sign that may be addressed to passersby, to the photographer himself or to us, the viewers. The Italian and Spanish words for “us” (noialtri and nosotros, respectively) are more than just the first person plural pronouns, encompassing as they do both Self and Other, like in Eyedentikit – an anti-documentary series if there ever was one. No sociology, no psychology and blindness as a condition for sight. Not even the mirror – the fair metaphor so beloved at the dawn of the history of photography, silvery and by now irremediably distant from today’s digital exploits, which Mastromatteo often, and apparently amusedly, resorts to – but the abyss, a game taken to the extreme consequence of identity loss (of the photographer rather than the subject; no Pirandello here). It is no coincidence that one of the greatest masters of documentary style in history, Walker Evans, chose to tackle a practice such as the stolen photo in his memorable series of portraits of passengers on the New York City Subway. Even less of a coincidence is how Evans described himself as “a penitent spy and an apologetic voyeur” in a letter accompanying the publication of some of these images; the linguistic slip compared to the voyant of poetic recollection is fascinating. Then again, when observing the faces made anonymous by Mastromatteo, we could almost repeat what the author of American Photographs once said of his own anonymous subjects: “As it happens, you don’t see among them the face of a judge or a senator or a bank president. What do you see is at once sobering and obvious: these are the ladies and gentlemen of the jury”.
Walter Guadagnini
Direttore di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, Torino
La giuria cieca
è un ritratto di Étienne
Carjat, una delle rare
testimonianze del volto
di Arthur Rimbaud.
Il poeta al quale più si avvicina Mastromatteo con questo lavoro, essendo gli occhi suoi sugli altri la traduzione perfetta del “Je est un autre” del genio francese. Ma quella fotografia è diventata, nei malati e creativi anni settanta newyorchesi, qualcosa di più e qualcosa d’altro, la maschera al quadrato di un artista non meno ribelle ed eccessivo dell’autore del Bateau ivre, quel David Wojnarowicz che si aggirava per le strade della Grande Mela con una maschera costituita per l’appunto dalla fotografia di Carjat. Rimbaud in New York, il didascalico titolo della serie, splendida e geniale, di un artista estremo, che si accompagnava ad altri dropouts di genio come Peter Hujar o Nan Goldin, decadenti di fine secolo come i loro predecessori attivi cent’anni prima nella capitale francese (a certificazione ulteriore dell’avvenuto trasferimento di centralità tra Europa e Stati Uniti a partire dalla metà dell’American Century). Ma, appunto, di Rimbaud si diceva, primariamente, e di Carjat, cioè delle origini della fotografia, di quel mezzo che ha modificato il nostro modo di vedere e di esperire il mondo, l’occhio meccanico tanto caro alle avanguardie tra surrealismo e Bauhaus, “il mezzo di espressione poetica più sicuro e il procedimento più agile per cogliere le più delicate osmosi esistenti tra la realtà e la surrealtà”, secondo le parole di un Dalí non ancora trasformatosi in Avida Dollars. Lo strumento che vede oltre il reale, e che dunque finisce per misurarsi con l’invisibile, con la cecità: non quella del veggente (ancora Rimbaud), ma quella del fotografo che si misura col mondo per paradossi, come Strand quando fotografa la mendicante cieca (ancora New York) e la scritta non si sa a chi sia rivolta, se ai passanti, al fotografo o a noi che guardiamo. Noialtri, nosotros, come dicono l’italiano e lo spagnolo almeno, non solo la prima persona plurale, l’io e l’altro da sé insieme, come in Eyedentikit, serie antidocumentarista se ce n’è una, niente sociologia e niente psicologia, la cecità come condizione della visione. Nemmeno lo specchio – quella metafora così bella e così amata ai primordi della storia della fotografia, argentata, ormai irrimediabilmente lontana dalle prodezze digitali d’oggi, di cui Mastromatteo fa ampio e si direbbe divertito uso –, ma proprio l’abisso, il gioco portato all’estrema conseguenza della perdita d’identità non del soggetto, ma del fotografo (nessun Pirandello qui): non è certo un caso se uno dei più grandi maestri di stile documentario della storia, Walker Evans, abbia voluto misurarsi con una pratica come quella della fotografia rubata nella memorabile serie di ritratti dei passeggeri della metropolitana newyorchese. E ancora meno casuale che in uno scritto che accompagna la pubblicazione di alcune di queste immagini, Evans si sia autodefinito come “a penitent spy and an apologetic voyeur”, con un interessante scivolamento linguistico rispetto al voyant di poetica memoria. D’altra parte, si potrebbe forse dire anche di questi volti resi anonimi da Mastromatteo quello che l’autore di American Photographs diceva dei suoi anonimi soggetti: “As it happens, you don’t see among them the face of a judge or a senator or a bank president. What do you see is at once sobering and obvious: these are the ladies and gentlemen of the jury”.